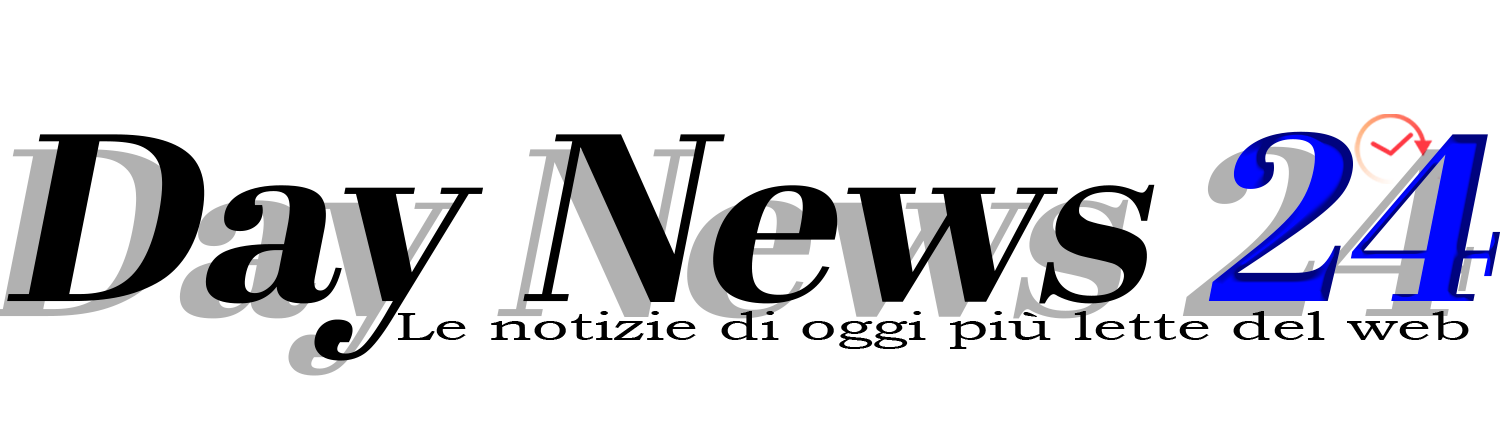Il ritorno del tema patrimoniale nel dibattito politico italiano, rilanciato dalle parole del segretario della Cgil Maurizio Landini, ha riaperto una discussione mai del tutto sopita. La proposta di un “contributo di solidarietà dell’1% sui patrimoni superiori ai due milioni di euro”, che secondo i calcoli del sindacato potrebbe fruttare circa 26 miliardi di euro, ha scatenato reazioni immediate. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha liquidato l’idea come una bandiera ideologica della sinistra, assicurando che sotto un governo di centrodestra una patrimoniale “non vedrà mai la luce”. Ma mentre in Italia il confronto si consuma sul piano politico, in Europa l’imposta sul patrimonio ha assunto forme più pragmatiche e differenziate.
Il modello francese e la svolta di Macron
Nel continente non esiste un modello unico di patrimoniale: alcuni Paesi l’hanno abolita, altri l’hanno trasformata, altri ancora la mantengono in versioni mirate. La Francia, storicamente simbolo di questo tipo di tassazione, nel 2018 ha sostituito l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) con l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI), limitandolo agli asset immobiliari e alleggerendo la pressione su investimenti mobiliari e finanziari. La scelta di Emmanuel Macron rispondeva al tentativo di frenare la fuga dei capitali e di rendere il Paese più competitivo agli occhi degli investitori.
Spagna e Svizzera: tra autonomia e stabilità
In Spagna, invece, la patrimoniale (Impuesto sobre el Patrimonio) è ancora in vigore, ma varia a seconda delle comunità autonome: la soglia di esenzione è fissata a 700 mila euro, con aliquote progressive dallo 0,2% al 3,5%. Alcune regioni, come Madrid, hanno deciso di azzerarla per attrarre ricchezza, mentre altre – tra cui la Catalogna – la mantengono con aliquote elevate. Il governo centrale ha introdotto nel 2023 un “impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”, una misura transitoria pensata per colmare le disparità regionali e finanziare politiche pubbliche post-pandemia.
In Svizzera, la patrimoniale è una realtà consolidata, ma gestita a livello cantonale. Le aliquote sono relativamente basse, comprese tra lo 0,1% e l’1%, ma la base imponibile è ampia e include quasi tutti i beni, finanziari e reali. Il modello elvetico funziona grazie alla stabilità fiscale complessiva e alla trasparenza amministrativa, due elementi che ne mitigano gli effetti distorsivi. Anche nei Paesi nordici, come Norvegia e Islanda, esistono forme di tassazione patrimoniale, sebbene moderate e integrate in un sistema fiscale fortemente progressivo e sostenuto da servizi pubblici di alta qualità.
Il bivio italiano: tra IMU e disuguaglianze
L’Italia, dal canto suo, conosce già strumenti di imposizione patrimoniale parziale: l’IMU sugli immobili, il bollo auto, l’imposta di bollo sui conti titoli e sui depositi bancari. Tuttavia, una vera imposta generale sulla ricchezza è sempre stata politicamente divisiva. I fautori della misura la considerano un mezzo per ridurre le disuguaglianze e finanziare servizi essenziali, mentre i detrattori temono che possa colpire il ceto medio, disincentivare il risparmio e provocare fughe di capitali in un contesto di alta mobilità finanziaria.
L’Italia si trova di fronte al bivio tra una visione redistributiva della fiscalità e la necessità di mantenere un ambiente competitivo per investimenti e crescita. In questo equilibrio precario si gioca il futuro della politica economica nazionale, tra giustizia sociale e sostenibilità finanziaria.
A cura di Dario Lessa
Leggi anche: Il giro del mondo a piedi, l’incredibile storia di Pieroad